Alluvioni e frane in Romagna: alcune riflessioni su gestione forestale e idrologia

Ascolta l'articolo
Nei giorni successivi all'evento meteorologico estremo che ha colpito la Romagna e causato devastanti alluvioni oltre a centinaia di frane e dissesti, sono state diverse le prese di posizione "a caldo", anche da parte di esperti (o presunti tali), che spesso sono risultate imprecise quando non palesemente errate e completamente fuori luogo.
Qualcuno ha parlato di ipotetiche "foreste vergini", altri hanno puntato il dito sulla "pulizia dei fiumi", altri ancora sull'abbandono dei territori rurali a monte delle aree colpite dall'alluvione.
Per fare chiarezza abbiamo posto ad un ricercatore forestale esperto di idrologia e dissesti in ambiente montano e boschivo, il Prof. Filippo Giadrossich dell'Università degli Studi di Sassari, alcune domande sui temi che stanno generando più confusione nei giornali e in TV.

In Italia ovviamente le "foreste vergini" invocate da qualcuno semplicemente non esistono. Ma lasciando da parte questa evidente semplificazione, la forma di governo dei boschi può incidere direttamente sui dissesti? Spesso al governo a ceduo viene associata una minore capacità di trattenuta dei versanti: è davvero così?
In realtà sia le foreste governate a ceduo che quelle governate a fustaia contribuiscono a mitigare l'erosione e le frane superficiali, senza differenze significative nella capacità di ritenzione idrica del suolo sulla base del tipo di governo. Questo vale anche per l’effetto di trattenuta dell’acqua da parte delle chiome, che viene perso dopo pochi millimetri di pioggia, indipendentemente dalla forma di governo. Pertanto, contrapporre fustaie, soprassuoli transitori, cedui o ipotetiche "foreste vergini" non ha molto senso in questo contesto. Bisogna fare attenzione a non cadere nella trappola "ceduo = dissesto". La capacità idrica nei suoli forestali è generalmente buona quale che sia la forma di gestione selvicolturale applicata, data dall'elevata porosità e capacità di drenaggio.
"L’effetto di trattenuta dell’acqua da parte delle chiome viene perso dopo pochi millimetri di pioggia, indipendentemente dalla forma di governo"
Alcuni commentatori hanno imputato un ruolo chiave alla siccità, persistente nei mesi precedenti al disastro, che sarebbe alla base di una minore capacità di trattenuta idrica dei suoli. Si tratta di un'ipotesi plausibile?
A mio avviso la siccità di questo inverno può aver influito solo in parte sugli allagamenti della Romagna. In condizioni di suolo molto secco e piogge intense si può determinare inizialmente un deficit di infiltrazione, con rapida saturazione dei primi centimetri e conseguente deflusso superficiale. Ma nei bacini montani, in bosco, è comunque molto raro osservare l'acqua che scorre in superficie, anche dopo lunghi periodi di siccità.
Numerose frane, si parla di diverse centinaia, sono scese nell'Appennino Tosco-Romagnolo. Quali soni i fattori che più incidono su questi fenomeni?
Fattori che contribuiscono alla suscettibilità del suolo a franare sono la pendenza, la tessitura, lo spessore dei suoli, la litologia. Altro fattore da considerare è il contenuto idrico del suolo prima dell’evento di pioggia. Dalle esperienze sperimentali e dalle osservazioni in campo di eventi naturali, l’innesco di frane si verifica quando piogge intense si abbattono su suoli che, a causa di eventi precedenti, hanno già un contenuto d'acqua significativo. Questo è ciò che è successo in Romagna, dove si sono verificati due eventi di pioggia estrema a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Ma un ulteriore fattore determinante sono gli interventi infrastrutturali di origine antropica, come, ad esempio, i "tagli di versante" costituiti da strade e i tombini, che concentrano le acque da un’ampia superficie in un solo punto, creando un rapido e localizzato accumulo con saturazione del suolo. In tali situazioni, anche terreni in pendenza con densa copertura delle chiome possono essere soggetti a franare.
"L’innesco di frane si verifica quando piogge intense si abbattono su suoli che, a causa di eventi precedenti, hanno già un contenuto d'acqua significativo"
Sulla manutenzione degli alvei si è sentito e si è letto davvero di tutto: alcuni hanno scritto che si taglia troppo, altri, al contrario, che non si fa più manutenzione. Qual'è la sua idea a riguardo?
La questione della manutenzione degli alvei riguarda principalmente la scelta di dove spostare il rischio, o il vantaggio. Infatti, la presenza di vegetazione erbacea, arbustiva e arborea sulle sponde, aumenta la scabrezza dell’alveo. Ciò comporta il rallentamento del deflusso e l’aumento dei livelli idrici, ma espone anche al rischio di trasporto di legname che può costituire una barriera in presenza di elementi strutturali. La gestione della vegetazione dipende quindi dalla scelta di usufruire dell’effetto positivo della vegetazione nella dinamica dei deflussi, con ripercussioni positive a valle in termini di riduzione dei picchi di piena, o dalla valutazione del rischio per le infrastrutture. La situazione è diversa nei tratti più a valle, dove i fiumi sono regolarizzati e progettati per lavorare in condizioni predeterminate di sezione idraulica e di scabrezza dell’alveo. Le opere di espansione del fiume possono controllare le portate per le quali gli argini sono stati progettati considerando specifici tempi di ritorno.
"La questione della manutenzione degli alvei riguarda principalmente la scelta di dove spostare il rischio, o il vantaggio"
In definitiva, come spesso capita volendo individuare a tutti i costi e in fretta un "colpevole", si attribuirsce ad un singolo fattore una concatenazione di eventi in realtà molto complessi, ma questo è profondamente sbagliato, è così?
Certamente, è sbagliato attribuire la responsabilità del rischio idrogeologico esclusivamente a un singolo fattore, come la gestione forestale ceduo/fustaia o gli eventi estremi che si verificano in seguito ai cambiamenti climatici. Le conseguenze di tali eventi sono sempre il risultato di una combinazione complessa di molteplici fattori. In primo piano rimangono le attività antropiche, il consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione temporanea o permanente, l'urbanizzazione mal pianificata, la modifica dei corsi d’acqua, l’occupazione delle naturali zone di espansione del fiume. Questi fattori possono alterare l'equilibrio idrogeologico naturale, aumentando la vulnerabilità del territorio agli eventi estremi.

Filippo Giadrossich, Dottore forestale, Dottorato in ingegneria agro-forestale a Firenze, insegna "Sistemazioni idraulico forestali" e "Valutazione del rischio idrogeologico" nel Corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali a Nuoro.
I principali temi di ricerca riguardano le foreste di protezione diretta ed il ruolo della vegetazione nella mitigazione delle frane superficiali.
ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE
Legno: la chiave per una gestione forestale continua
In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?
Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane
Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi
Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani
Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali
Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze
All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità
Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.
Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici
Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob
Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio
Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.
Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana
Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime
Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale
Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.
La professione forestale nell’era della closer to nature selvicolture, un seminario ad UNIFI
Quali sono i possibili sbocchi professionali della laurea in Scienze Forestali? Come sta cambiando il settore alla luce dei recenti sviluppi in direzione di una selvicoltura più vicina alla natura
È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?
L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.
Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!
Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.
Tra ciliegi e social network
Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura
Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"
Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico
Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci
Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani
Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.
La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini
Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi
Antennae - Se gli alberi potessero registrarci
Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.
Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri
Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.
La sostenibile leggerezza del legno
“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti
Il suono del legno
Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.





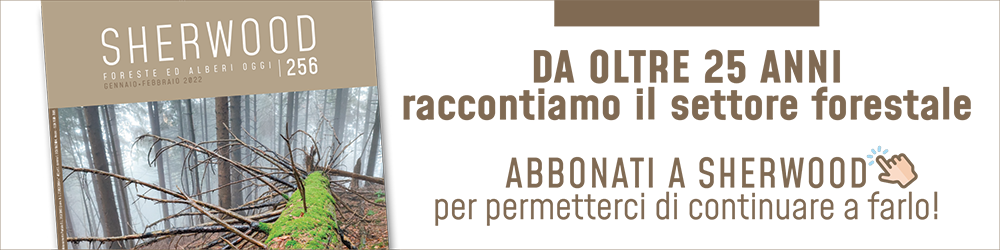
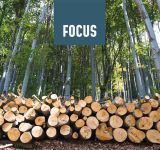
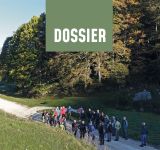















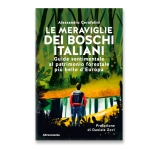
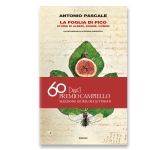
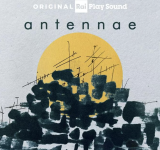
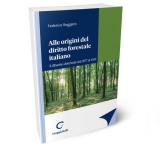














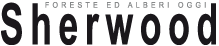


 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.