Castanicoltura da legno: stato dell’arte e criticità
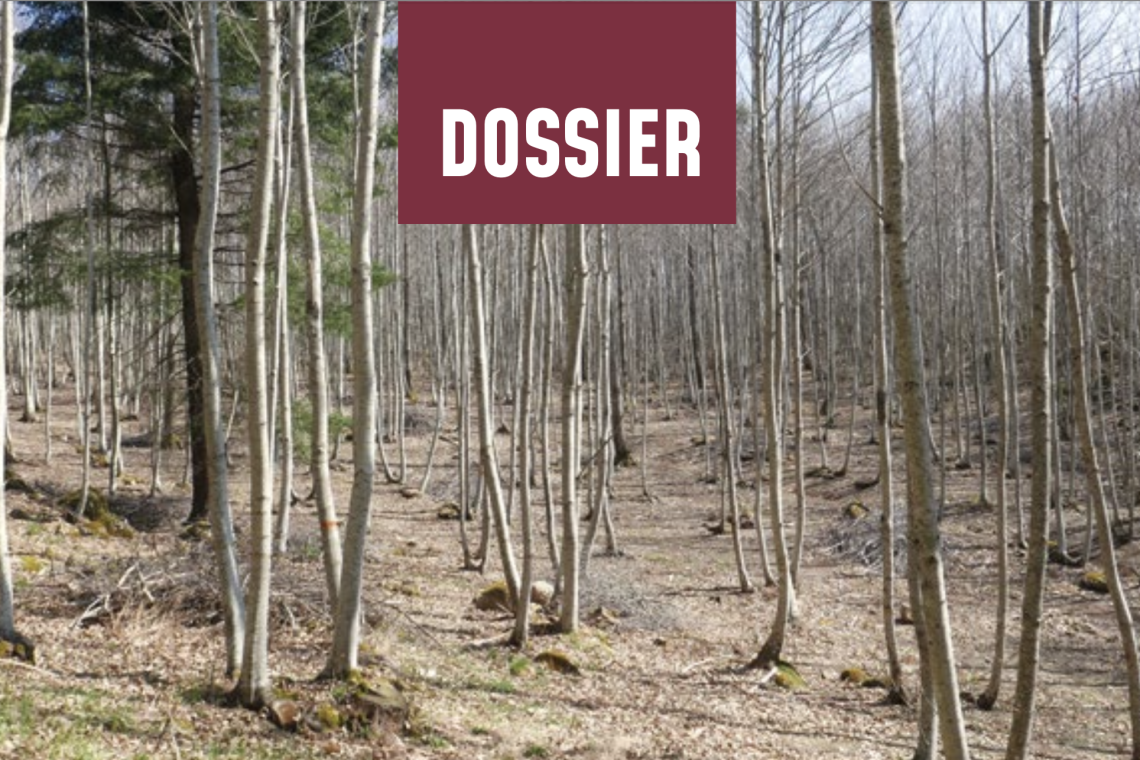
Questa è l'introduzione del DOSSIER pubblicato sul numero 266 di Sherwood | Foreste e Alberi oggi, la versione integrale è disponibile solo per gli abbonati nella versione cartacea, nella APP e sul sito, come sfogliabile, mentre attendete che la vostra copia arrivi a casa. Abbonandoti non solo avrai accesso a questo e ad altri contenuti riservati ma contribuirai a sostenere tutto il lavoro della Redazione di Sherwood. Visita la sezione dedicata agli abbonamenti cliccando qui.
di Silvia Bruschini - Redazione di Sherwood
I boschi di castagno in Italia ricoprono una superficie complessiva di 778.475 ha (INFC 2015) di cui circa 1/5 definiti come “Castagneti da frutto, selve castanili” e 4/5 (592.348 ha) come “Castagneti da legno”, proporzione tra queste due categorie che oggi risulta ribaltata rispetto all’ultimo dopoguerra a causa sia dei cambiamenti socioeconomici sia delle problematiche fitosanitarie sempre più impellenti.
Benché la definizione inventariale “castagneti da legno” faccia esplicito riferimento alla funzione produttiva e quindi sottintenda una gestione attiva, oggi una parte significativa di questi soprassuoli sono in pieno abbandono colturale. Si tratta per lo più di cedui lasciati ad evoluzione post-colturale o di cedui derivanti dal taglio dei castagneti da frutto caratterizzati da una bassa densità di ceppaie e/o individui. Considerata la forte connotazione di artificialità che caratterizza i cedui di castagno, l’abbandono colturale (intendendo periodi di oltre 50 anni dall’ultima ceduazione senza alcun intervento) porta inevitabilmente questi soprassuoli ad una fase di disequilibrio e di instabilità meccanica, favorendo l’innesco di fenomeni franosi, l’ingresso di specie mesofile e la riduzione del numero di ceppaie di castagno.
Le potenzialità e le caratteristiche peculiari di questa specie, quali la capacità pollonifera praticamente illimitata, gli accrescimenti sostenuti soprattutto in fase giovanile e la produzione, a seguito di un’idonea gestione, di legname di buona qualità e apprezzato dal mercato, impongono di considerare, ove opportuno, il recupero dei soprassuoli abbandonati e, comunque, la valorizzazione dei cedui gestiti.
La ricerca, che già dagli anni ’70 si è posta il problema di trovare soluzioni selvicolturali alternative al ceduo a turno breve si è concentrata dagli anni ‘90 nella definizione di modelli di trattamento finalizzati alla produzione legnosa di qualità con l’obiettivo di affrontare il tema in tutta la sua complessità, analizzando le connessioni tra biologia, selvicoltura, tecnologia ed economia della filiera legno.
Grazie a sperimentazioni ultratrentennali oggi abbiamo le conoscenze per capire se e quando è il caso di recuperare un ceduo oltre il turno (cioè, che ha oltrepassato l’età del turno consuetudinario ed è lasciato ad evoluzione naturale) e come farlo.
Il Dossier che proponiamo in questo numero di Sherwood raccoglie infatti i principali risultati di queste ricerche ed è stato proposto e realizzato da un consolidato gruppo di ricercatori “esperti del castagno” principalmente provenienti dal CREA, centro di ricerca Foreste e Legno, dal TESAF dell’Università degli Studi di Padova e dal WSL, Istituto di ricerca svizzero, che ringraziamo per il notevole lavoro svolto. L’obiettivo di questo Dossier è quello di mostrare il percorso da intraprendere nella valutazione di castagneti da legno potenzialmente produttivi e nella scelta del modello selvicolturale da applicare per ottenere una produzione legnosa da destinare ai vari assortimenti di paleria, a segagione o a produzione di piallacci.
Ma le indicazioni derivanti dai risultati della ricerca sono sempre ed ovunque applicabili?
Purtroppo, questa è una domanda retorica e la risposta è “NO!”
Ciò che l’evidenza scientifica indica come percorso selvicolturale da seguire potrebbe infatti essere ostacolato dalle norme regionali che, in Italia, spesso non considerano la complessità, le peculiarità (ed anche le opportunità) della castanicoltura da legno. A tal proposito nel Dossier si trova anche un contributo con alcune esperienze estere, in linea con gli indirizzi colturali innovativi proposti, ma applicati senza restrizioni normative.
Obiettivo del Dossier è quindi anche quello di evidenziare alcune criticità (segnalate anche graficamente nella trattazione e sintetizzate al termine di ogni contributo in un’apposita finestra) così da sensibilizzare il mondo tecnico e quello istituzionale sulla necessità di un aggiornamento utile a determinare quelle modifiche normative e gestionali indispensabili per rendere applicabili ed efficaci le indicazioni tecniche oggi disponibili.
Vuoi continuare a leggere i contenuti di questo DOSSIER?
Abbonati subito e avrai la possibilità di accedere a tutti i numeri arretrati in formati digitale, scopri come cliccando qui.
ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE
Legno: la chiave per una gestione forestale continua
In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?
Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane
Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi
Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani
Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali
Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze
All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità
Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.
Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici
Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob
Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio
Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.
Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana
Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime
Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale
Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.
La professione forestale nell’era della closer to nature selvicolture, un seminario ad UNIFI
Quali sono i possibili sbocchi professionali della laurea in Scienze Forestali? Come sta cambiando il settore alla luce dei recenti sviluppi in direzione di una selvicoltura più vicina alla natura
È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?
L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.
Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!
Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.
Tra ciliegi e social network
Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura
Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"
Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico
Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci
Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani
Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.
La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini
Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi
Antennae - Se gli alberi potessero registrarci
Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.
Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri
Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.
La sostenibile leggerezza del legno
“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti
Il suono del legno
Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.





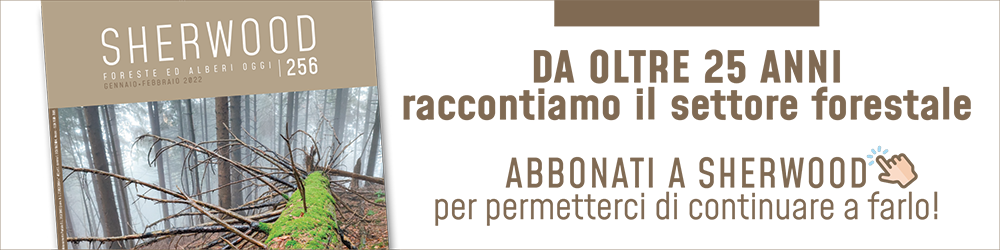
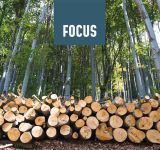
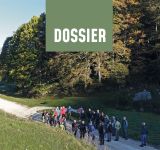















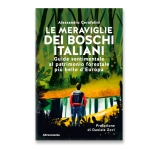
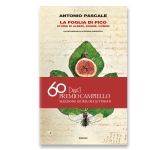
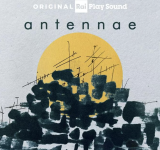
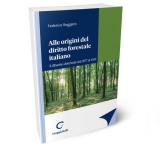














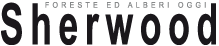


 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.