Faggete a basse quote: come hanno influito clima e attività antropiche sulla loro attuale distribuzione?

Ascolta l'articolo
di Mauro Buonincontri, Luciano Bosso, Sonia Smeraldo, Maria Luisa Chiusano, Salvatore Pasta, Gaetano di Pasquale
Il faggio - Fagus sylvatica - è conosciuto in Italia come una specie forestale tipica della fascia montana dove attualmente è presente dagli 800 ai 2000 m s.l.m., ma non è sempre stato così. Un recente studio mostra come il faggio occupasse in passato una superficie molto più ampia rispetto a quella attuale. Lo spostamento di questa specie verso quote più elevate e la sua scomparsa dalle zone poste al di sotto dei 300 m s.l.m di quota sembra esser stata causata dalla combinazione di due diversi fattori: i cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 4.000 anni e le attività antropiche.
Il faggio, Fagus sylvatica, è una specie ampiamente diffusa in Europa: la sua distribuzione spazia dalla Sicilia alla Scandinavia e dalla penisola iberica ai Carpazi. In Italia le faggete coprono una superficie di circa 1 milione di ettari, il faggio rappresenta una delle specie più diffuse a livello nazionale (INFC 2015) ed è attualmente presente in popolamenti naturali in tutte le regioni dell’Italia tranne che in Sardegna.
Il faggio è una delle specie arboree più utilizzate in Europa. La sua resistenza e le eccellenti capacità elastiche rendono il suo legno un materiale ideale per la costruzione di mobili, pavimentazioni, scale, strumenti musicali, compensati, pannelli, impiallacciature e utensili da cucina. Il faggio viene inoltre utilizzato da sempre come legna da ardere e carbone per il suo elevato potere calorifico.
In Italia il faggio è presente principalmente nella fascia altimetrica compresa tra gli 800 e i 2000 m s.l.m. Tuttavia, individui isolati possono essere rinvenuti anche a quote inferiori ai 200 m s.l.m. Se si escludono le aree dove sono presenti individui sporadici, il pensiero comune sino a oggi è sempre stato che l’attuale limite inferiore delle faggete (800 m s.l.m.) fosse dovuto soltanto alle condizioni climatiche (scarse precipitazioni ed elevate temperature). In una parte della comunità scientifica nazionale, tuttavia, l’idea che in passato il faggio occupasse una fascia altitudinale ben più ampia si è fatta strada da tempo e numerose osservazioni di campo hanno suggerito che il clima non fosse l’unica causa dell’assenza del faggio a quote inferiori a 800 m s.l.m.
In un nostro recente studio appena pubblicato su un’importante rivista scientifica, "Science of The Total Environment", dal titolo “Shedding light on the effects of climate and anthropogenic pressures on the disappearance of Fagus sylvatica in the Italian lowlands: evidence from archaeo-anthracology and spatial analyses”Fagus sylvatica“Shedding light on the effects of climate and anthropogenic pressures on the disappearance of Fagus sylvatica in the Italian lowlands: evidence from archaeo-anthracology and spatial analyses” abbiamo provato a fare maggior chiarezza su questo tema.

Lo studio
Per realizzare questa ricerca abbiamo incrociato il censimento dei siti archeologici della penisola italiana posti a quote inferiori a 600 m s.l.m. dove sono stati recuperati resti di faggio (nella forma di legname, carboni, foglie e frutti), con applicazioni di GIS e di modellistica ecologica per ricostruire la passata distribuzione potenziale di Fagus sylvatica.
I nostri risultati hanno dimostrato che:
- nel corso degli ultimi 4.000 anni l’estensione dell’area di distribuzione potenziale del faggio si è ridotta di circa 48% e la specie si è spostata verso l’alto di circa 200 m;
- il clima sembra aver influenzato tutto l’intervallo altimetrico analizzato nello studio (0–300, 300–600, 600–900 e >900 m s.l.m.) ma, in percentuale maggiore, la distribuzione alle quote superiori ai 300 m s.l.m.;
- in alcune aree la rarefazione del faggio è probabilmente dovuta all’effetto combinato del cambiamento del clima e dell’impatto delle attività antropiche. In particolare, le zone in cui è stata più forte l’azione antropica sono risultate quelle a quote inferiori di 300 m s.l.m.;
- considerando solo l’impatto antropico invece, questo si è concentrato maggiormente nella fascia altitudinale di bassa quota (0-50 m s.l.m.), che è la zona altimetrica che copriva più del 43% delle faggete incluse tra 0 e 300 m s.l.m.
È bene sottolineare che questo nostro lavoro costituisce un primo tentativo di applicare un approccio innovativo e multidisciplinare per mostrare un punto di vista differente, in grado di interpretare in modo alternativo la storia delle faggete italiane di bassa quota e di quantificare l’impatto del clima e dell’azione umana su questo ecosistema forestale. Siamo ben consapevoli del fatto che ulteriori approfondimenti serviranno a chiarire ulteriormente questo interessante e delicato argomento.
Riflessioni
L’effetto combinato del cambiamento climatico avvenuto negli ultimi 4.000 anni e dell’attività antropica sembra aver fortemente influenzato la scomparsa del faggio nei boschi italiani di bassa quota, soprattutto nelle fasce costiere, di pianura e collina. Anziché chiamare in causa un singolo fattore naturale come il clima, come è stato fatto da molti studiosi sino ad oggi, lo spostamento verso quote più alte delle faggete in Italia può essere spiegato in maniera più convincente ipotizzando l’azione sinergica dei due diversi fattori analizzati. La differenza sostanziale fra i processi naturali e quelli di origine antropica sta nei tempi di azione. In linea di massima, infatti, gli interventi operati dall’uomo sono in grado di cambiare drasticamente un paesaggio in un arco temporale decisamente più breve rispetto al clima. Nonostante la graduale “mediterraneizzazione” del clima, infatti, all’inizio del periodo considerato (4.000 anni fa) il faggio era ancora presente nei boschi dalla collina fino alla costa, dove però si sono progressivamente diffuse non solo specie arboree più termofile, ma anche specie coltivate, frutto di una crescente influenza delle attività agro-forestali svolte attorno agli insediamenti umani. Un’influenza che ha portato, nella fascia planiziale-collinare, alla diffusione di alberi di grande interesse economico, come il castagno, e di altre specie arboree da frutto o a più rapido accrescimento per la produzione legnosa.
Vale la pena di sottolineare che studi come il nostro possono fornire spunti per orientare correttamente le future politiche di gestione del patrimonio forestale italiano, contribuendo allo stesso tempo alla sua conservazione. I risultati del nostro lavoro ricevono peraltro continue conferme dalle osservazioni di campo effettuate in diversi siti dell’Italia peninsulare, dove in seguito alla cessazione della gestione attiva dei boschi si sta assistendo al progressivo ingresso (ma forse è più corretto parlare di ritorno) del faggio in popolamenti posti a quote inferiori a 800 m s.l.m. Il processo di ricolonizzazione da parte di F. sylvatica è garantito dalla presenza di individui maturi che, anche se isolati, mostrano ottime capacità di dispersione dei semi.
Questa ricerca sulle dinamiche vegetazionali del passato, che ha visto dialogare e confrontarsi archeobotanici, esperti di analisi spaziale ed ecologi forestali, fornisce spunti preziosi per meglio capire la storia e l’eredità dei nostri boschi e sviluppare nuove strategie per la loro conservazione e il loro ripristino. Alla luce dei nostri risultati, ad esempio, avrebbe senso una maggiore tutela delle piante portaseme di faggio poste alle quote più basse, prendendo in considerazione le aree individuate dai modelli come più idonee. In un’ottica di tutela di tale specie e di incremento della biodiversità sarebbe possibile mantenere una gestione forestale attiva pur tutelando la presenza sporadica del faggio a basse quote, azione auspicabile in special modo all’interno delle aree protette. È vero che l’attuale emergenza climatica, un cambiamento molto più rapido rispetto a quello avvenuto nei 4.000 anni presi in esame dallo studio, potrebbe sfavorire la ridiffusione del faggio a basse quote, a causa dell’aumento delle temperature, di siccità e ondate di calore. Tuttavia, la strada della ridiffusione tramite il rilascio di portaseme può essere comunque tentata, monitorando costantemente il comportamento della rinnovazione.
Nel nostro lavoro abbiamo mostrato come l’intreccio di più competenze può portare a risultati interessanti per comprendere meglio le complesse interazioni “pianta-clima-attività antropiche”. Un approccio di importanza strategica che può essere applicato ad altre specie e persino ad interi popolamenti, fornendo strumenti ed indirizzi idonei a limitare l’impatto antropico su ecosistemi importanti come quelli forestali.

Distribuzione del faggio in Italia nel tardo Olocene, distribuzione attuale della specie ed effetto combinato di modificazione del clima e attività antropiche.
Autori:
Mauro Buonincontri, archeobotanico presso il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena
Luciano Bosso, ecologo che collabora con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Sonia Smeraldo, ecologa che collabora con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Maria Luisa Chiusano, Professoressa di Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Salvatore Pasta, ricercatore presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR di Palermo
Gaetano di Pasquale, Professore di Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”).
Foto di copertina: Mauro Buonincontri
Foto interne: Luciano Bosso
Il lavoro scientifico da cui è tratto l'articolo è disponibile a questo link.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Luciano Bosso, coautore dell'articolo: luciano.bosso@unina.it
ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE
Legno: la chiave per una gestione forestale continua
In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?
Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane
Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi
Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani
Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali
Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze
All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
Workshop tracciabilità e qualità delle biomasse legnose
AIEL, UNIFOL e ARIBT organizzano un workshop rivolto a ditte, tecnici e forestali per parlare di tracciabilità e qualità delle biomasse legnose.
A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità
Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.
Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici
Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob
Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio
Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.
Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana
Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime
Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale
Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.
È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?
L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.
Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!
Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.
Tra ciliegi e social network
Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura
Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"
Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico
Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci
Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani
Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.
La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini
Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi
Antennae - Se gli alberi potessero registrarci
Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.
Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri
Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.
La sostenibile leggerezza del legno
“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti
Il suono del legno
Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.






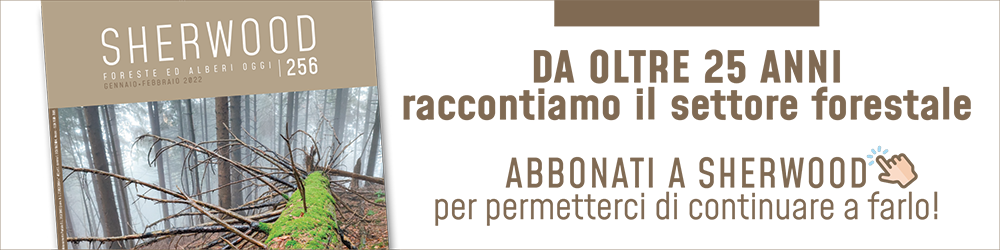
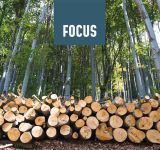
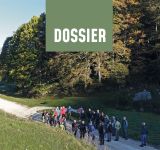















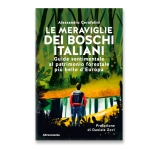
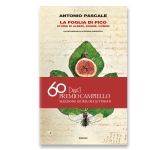
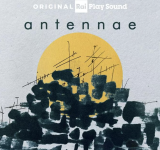
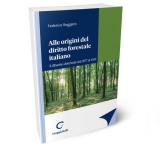














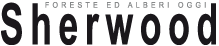


 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.