La funzione protettiva degli schianti per evitare opere inutili

Ascolta l'articolo
di Bruno Crosignani
La gestione dei rischi dopo la tempesta Vaia ha evidenziato, in alcuni contesti, l’assenza delle competenze forestali nelle scelte attuate. Si riportano alcuni esempi in cui la funzione protettiva degli schianti è stata ignorata o comunque sottovalutata, in favore della realizzazione di opere di protezione costose ed impattanti. In questi contesti la professionalità forestale è stata silente o snobbata? Nel contributo si analizzano alcune situazioni nell’ottica di evitare in futuro analoghe scelte discutibili.
La tempesta Vaia, inedita per dimensioni e modalità di svolgimento ha costituito un precedente nell'ambito delle avversità che periodicamente colpiscono i nostri boschi. Ha interessato gran parte del Nord-Est del Paese, abbattendo piante per oltre 14 milioni di m³di legname e radendo al suolo o danneggiando in modo consistente oltre 40.000 ha di foreste. La quantificazione dei danni causati è del tutto provvisoria: ad essi bisognerà aggiungere quelli dovuti allo sviluppo dei parassiti, soprattutto dall'Ips typhographus sull'abete rosso, in pieno svolgimento.
Nell'opera di recupero del legname e mitigazione del rischio derivante dal danneggiamento delle aree forestali una particolare attenzione è stata rivolta alle mutate condizioni dei boschi con funzione protettiva delle opere civili, abitati, strade, elettrodotti, ecc.
Percezione dei cittadini vs. conoscenze dei forestali
A livello di opinione pubblica la richiesta unanime è stata quella di rimuovere tutti gli alberi a terra “ripulendo” i boschi prima possibile e rimboschendo subito con tante nuove piantine. Addirittura, si è data pubblicità all'intenzione di eliminare le ceppaie presenti sui versanti con l'uso di esplosivo.
Le parole hanno un peso e svelano il contesto culturale di chi le usa. Da subito le comunicazioni dei media hanno parlato di “bosco sparito”, “bosco annullato”, “bosco che non c'è più”.
Spesso le stesse espressioni sono state usate nelle relazioni tecniche a supporto dei progetti di mitigazione del rischio sui versanti posti a monte delle suddette opere civili, con una descrizione semplicistica dell'ambiente bosco, visto meramente come un insieme di alberi in posizione verticale.
Chi del bosco ha una conoscenza appena più approfondita sa - e ha perso forse una straordinaria occasione di farlo sapere - che un bosco in cui le piante cadono non “sparisce”, ma semplicemente entra in una fase nuova, che presenta caratteristiche diverse sia di tipo morfologico che funzionale.
Il bosco in cui le piante cadono non “sparisce”, ma semplicemente entra in una fase nuova
E ad accorgersi tra i primi di questo è stato, sorprendentemente, non un tecnico ma un artista. Durante un’intervista, infatti, il celebre direttore d'orchestra Ezio Bosso ha affermato che “gli alberi si sono sacrificati e hanno protetto la valle”. Affermazione sorprendente e apparentemente illogica, dato che il sacrificio, per noi, implica una coscienza, un'intenzione. In realtà essa esprimeva non un ragionamento, ma una intuizione sul bosco, come organismo resiliente, che muta forma ma non “scompare”.
Di questo si comincia solo ora a rendersene conto, vedendo come situazioni che apparivano angoscianti vengano pian piano ricondotte nei giusti termini dall'osservazione di come il terreno sia ricoperto dal mantello protettivo delle piante atterrate e dal lento, costante procedere della ripresa del bosco. Boschi dove gli alberi non sono stati rimossi, in zone in vista che colpivano l'occhio dando un senso di sconvolgimento, si stanno ricoprendo di arbusti che ricompongono il paesaggio nascondendo le piante atterrate e preparando il terreno per gli alberi. Inoltre, il “mantello” protettivo del terreno è ancora più efficace rispetto alle piante in piedi, e per un periodo non breve, contro la caduta di sassi ed è estremamente valido contro la formazione delle valanghe.
A riprova di ciò sia gli studi svizzeri condotti a seguito degli
uragani Vivian nel 1990 e Lothar nel 1999 [1], sia l'esperienza delle recenti nevicate eccezionali del 2020-21 nell'area dolomitica (con altezza di neve anche oltre i 2 metri in pochi giorni!), non hanno fatto registrare alcuna valanga generatasi nel bosco atterrato.
Il rilascio degli schianti a terra porta benefici anche per la rinnovazione naturale. Dove già presente e dove la disseminazione naturale si può diffondersi dai boschi circostanti, il bosco si ricostituirà più velocemente rispetto a dove lo sgombero del legname ha “desertificato” il suolo costringendo in molti casi a ricorrere al rimboschimento artificiale.
Opere di protezione sostitutive
Certamente lo sgombero del legname è stato quasi sempre economicamente utile e opportuno nei boschi che non svolgono funzioni di protezione diretta di strutture civili. Dove invece questi si trovano a monte di abitati o strade la loro rimozione ha portato alla realizzazione di opere di protezione dal costo molto elevato e impattanti sull'ambiente.
In boschi di protezione, lo sgombro ha portato la realizzazione di opere costose ed impattanti sull'ambiente
Un insieme di fattori quali: l'assunto concettuale semplicistico del “bosco scomparso” che ha informato anche l'approccio di molti tecnici, i timori e l'attesa di operatività da parte dell'opinione pubblica, la portata senza precedenti dell’evento Vaia e l'urgenza di utilizzare i fondi di emergenza disponibili per un periodo limitato, hanno fatto talvolta adottare provvedimenti non sufficientemente ponderati, realizzando opere la cui funzione avrebbe potuto essere svolta altrettanto bene dal bosco nello stato in cui si trovava.
La progettazione delle opere si è basata su modelli matematici del terreno secondo procedure standard elaborate per il rischio valanghe e generalmente accettate, che simulano le condizioni per la formazione di un piano di scivolamento della neve. I modelli tengono conto di vari parametri quali pendenza, esposizione, quota, dati nivometrici delle stazioni di rilevamento più prossime, ecc. Viene tenuto conto anche dell'accidentalità del terreno, attraverso la stima di coefficienti che tuttavia sono difficilmente calcolabili. Se nel caso di terreni di alta quota, privi di alberi, ove il terreno è erboso il modello può funzionare bene data l'omogeneità del profilo (l'accidentalità data dalle zolle erbose è sull'ordine decimetrico, molto al di sotto del normale spessore della neve che quindi “livella” facilmente il profilo), nel caso di terreni a bosco, anche quando il legname sia stato allontanato l'accidentalità data dalla presenza delle ceppaie ribaltate, dei residui del taglio e l'orografia spesso più irregolare rispetto alle praterie in quota rende l'applicabilità dei modelli matematici più aleatoria, dato che l'irregolarità del profilo, che ostacola la formazione delle valanghe, è dell'ordine metrico, quindi paragonabile a quello raggiungibile spesso solo da nevicate eccezionali.
Anche nel contesto svizzero quando viene a crollare una foresta a monte di abitati, la realizzazione di opere artificiali sembra essere la regola, a conferma che fattori non tecnico-economici come “opinione pubblica”, “tutela dalle responsabilità”, “opportunità professionali”, hanno il loro peso ovunque! Non e però accettabile decidere, sotto la spinta dell'opinione pubblica e per il timore di venir tacciati di inattività, di realizzazione di opere costose e tecnicamente valutabili come inutili come il rivestire sistematicamente i pendii di fermaneve a monte delle strade. Non trovano infatti motivazioni razionali, queste scelte fatte eludendo la verifica puntuale in loco dell'azione positiva che il bosco atterrato può svolgere e la possibile adozione di approcci alternativi validi ed economici quale il rilascio delle piante a terra, con monitoraggio in occasione di eventi eccezionali e l'eventuale integrazione localizzata della rinnovazione naturale.
Anche nella protezione dalla caduta massi in taluni casi l'azione sulla morfologia del terreno, con la rimodellazione locale a formare valli e tomi, dove il bosco può ricrescere ed essere compatibile con la normale gestione forestale risulta meno costoso e impattante del ricorso a barriere in acciaio, soggette a costose manutenzioni o riparazioni in caso di danneggiamento e penalizzanti per l'utilizzo del bosco a monte.
Professionalità forestale silente o snobbata?
Purtroppo, nella gestione dei rischi a seguito della tempesta Vaia le conoscenze sulla dinamica del bosco sono state quasi sempre ignorate ed il ruolo degli schianti in funzione protettiva è stato escluso del tutto o ampiamente sottovalutato. Le conoscenze e la professionalità proprie dei forestali, che avrebbero potuto essere di valido supporto nelle decisioni sono state quasi sempre ignorate, affidandosi alla tecnicità di ingegneri e geologi, normalmente a loro agio più con i modelli matematici che con le osservazioni delle dinamiche naturali. In questo ha sicuramente avuto un peso una certa arrendevolezza dei forestali rispetto al valore delle proprie conoscenze ed esperienza nonché lo scarso peso della figura del forestale all'interno delle amministrazioni anche riguardo al campo di azione proprio.
È utile una maggiore comunicazione e collaborazione tra professionalità diverse: ingegneri, forestali, geologi, architetti…
L'impressione è che in questa circostanza la professionalità forestale sia stata o silente o snobbata.
Un miglioramento anche tra i tecnici delle conoscenze sulle dinamiche del bosco e una maggiore comunicazione e collaborazione tra professionalità diverse (ingegneri, forestali, geologi, architetti) in questo settore consentirebbe di attuare pratiche più in sintonia con l'ambiente, evitando sprechi di risorse e dando un seppur piccolo contributo all'attuazione di quella “transizione ecologica”, che spesso rimane sulla carta o relegata nelle parole dei convegni. Di seguito alcuni esempi osservati in Val di Fiemme (Trentino) che supportano quanto espresso.
 Predazzo, Monte Mulat - Fermaneve naturali sostituiti con opere artificiali. Da notare anche l'eliminazione delle piante ancora in piedi necessaria per la realizzazione delle opere e la “desertificazione” del suolo ove già era presente della rinnovazione naturale. Anche economicamente il ricavato della vendita del legname (20-30.000 €) non è paragonabile con il costo delle opere (circa 1.500.000 €). Di fatto l'intrico di ceppaie e tronchi di 40-70 cm di diametro, alto da 1,5 a 3,0 metri e più e con tempi di degrado di almeno 20-30 anni è stato sostituito da rastrelliere fermaneve formate da tronchetti di 16-28 cm, alti 2,0 metri di cui si stima una durata di circa 20 anni con possibile necessità di manutenzioni nel periodo.
Predazzo, Monte Mulat - Fermaneve naturali sostituiti con opere artificiali. Da notare anche l'eliminazione delle piante ancora in piedi necessaria per la realizzazione delle opere e la “desertificazione” del suolo ove già era presente della rinnovazione naturale. Anche economicamente il ricavato della vendita del legname (20-30.000 €) non è paragonabile con il costo delle opere (circa 1.500.000 €). Di fatto l'intrico di ceppaie e tronchi di 40-70 cm di diametro, alto da 1,5 a 3,0 metri e più e con tempi di degrado di almeno 20-30 anni è stato sostituito da rastrelliere fermaneve formate da tronchetti di 16-28 cm, alti 2,0 metri di cui si stima una durata di circa 20 anni con possibile necessità di manutenzioni nel periodo.
La soluzione “naturale”, pure prospettata, non è stata accolta.
 Ville di Fiemme, Passo Lavazè - Tomo paravalanghe a protezione della strada statale. In primo piano la piazzola terminale di una strada forestale realizzata per il recupero del legname. L'orografia, la presenza di rinnovazione naturale, di ceppaie di grosse dimensioni e della strada sarebbero di per sé sufficienti a rendere sicuro il pendio.
Ville di Fiemme, Passo Lavazè - Tomo paravalanghe a protezione della strada statale. In primo piano la piazzola terminale di una strada forestale realizzata per il recupero del legname. L'orografia, la presenza di rinnovazione naturale, di ceppaie di grosse dimensioni e della strada sarebbero di per sé sufficienti a rendere sicuro il pendio.
Soluzioni più naturali/forestali
In alternativa all'approccio marcatamente tecnicistico seguito nei casi sopra riportati, sempre nei pressi del passo di Lavazè è stata riservata un'area di circa 20 ha posta a monte della strada statale ove le piante atterrate verranno lasciate in posto a protezione dalle valanghe, in accordo con l'amministrazione comunale e con la locale Commissione valanghe. Contemporaneamente è stata realizzata una strada forestale, già prevista prima della tempesta Vaia e 2 sentieri che consentiranno di accedere all'area e svolgere attività di ricerca e divulgazione sulle dinamiche di ricostituzione naturale del bosco.
Un area per svolgere ricerca e divulgazione sulle dinamiche di ricostituzione naturale del bosco
In questo caso si è stimato che dall'utilizzazione del bosco si sarebbero potuti ricavare 60-80.000 €, mentre la protezione con opere fermaneve avrebbe avuto un costo stimabile in oltre 1.500.000 €.
Una nota positiva…
Il Comune di Moena in Val di Fiemme aveva progettato la realizzazione di paramassi e di una linea fermaneve in bosco a protezione della frazione di Forno, ottenendone il finanziamento. Nel corso dell'iter di autorizzazione del progetto, in base a un'osservazione più approfondita sulle caratteristiche del sito e del bosco atterrato, non completamente esboscato, le strutture locali deputate al rilascio delle autorizzazioni forestali, paesaggistiche e urbanistiche, in accordo con i progettisti hanno rilevato l'utilità dei paramassi ma hanno riconosciuto che l'azione di contrasto alla formazione di valanghe poteva essere assolta dalla combinazione di accidentalità del terreno e presenza di ceppaie divelte e fusti ancora in posto, togliendo dal progetto la realizzazione dei fermaneve (rastrelliere). Di più, il Comune di Moena, committente dell'opera, ha riconosciuto al proprietario del bosco, la Regola Feudale di Predazzo, un rimborso pari al valore di macchiatico delle piante non esboscate.
A fronte di un indennizzo per 2.000 € quindi, si avuto un risparmio dalla mancata realizzazione dei fermaneve di oltre 30.000 €!
A fronte di un indennizzo per 2.000 € quindi, si avuto un risparmio dalla mancata realizzazione dei fermaneve di oltre 30.000 €. Un piccolo ristoro quindi, quantitativamente molto inferiore alla funzione di protezione svolta dal bosco atterrato, ma un primo passo verso il riconoscimento concreto del valore intrinseco del bosco quale fornitore di “servizi ecosistemici”, termine di origine recente ancora spesso oggetto solo di enunciazioni di principio.
Autore:
Bruno Crosignani, già direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.
ULTIMI ARTICOLI e NOTIZIE
Legno: la chiave per una gestione forestale continua
In Italia proprietari e gestori forestali sono spesso in balia delle oscillazioni del mercato del legno, rese ancora più imprevedibili dalla crisi climatica. Quali sono le soluzioni possibili?
Associazionismo: una sfida antica e nuova per le foreste italiane
Il tema della cooperazione e del “fare rete” sono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale quadro politico e sociale e dalla necessità di scelte strategiche imposte anche dalla crisi
Grandi Foreste Regionali: 10 principi per guidare la gestione dei boschi italiani
Il 12 Aprile, presso il MASAF, si è tenuto un evento per parlare del futuro della gestione dei boschi italiani e del ruolo dei demani regionali
Il castagneto didattico innovativo e sperimentale di AUSF Firenze
All’Orsigna il castagneto didattico innovativo e sperimentale di Ausf Firenze
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
È online SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
SINFor: il primo Sistema Informativo Nazionale Forestale
A Palermo il primo Forum Nazionale della Biodiversità
Il National Biodiversity Future Center (NBFC) organizza a Palermo un grande evento scientifico, il primo Forum Nazionale della Biodiversità.
Scivolone olimpico: in libreria un “instant book” sul caso della pista da bob di Cortina, con un saggio sul taglio dei larici
Luigi Torreggiani ha firmato un saggio all’interno del nuovo volume “Scivolone olimpico”, dedicato al caso del taglio dei larici a Cortina d’Ampezzo per la realizzazione della pista da bob
Ecobase, leader nei progetti di forestazione per il carbonio
Ecobase, operatore leader nei progetti di forestazione per il carbonio, introduce un nuovo programma in Italia per i proprietari terrieri.
Il recupero dei castagneti da frutto: scambio di esperienze tra Calabria e Toscana
Un evento a Sant’Agata d’Esaro per dare il via ad un ambizioso progetto di recupero dei castagneti italiani, basato sullo scambio di conoscenze e lo sviluppo di attività dimostrative e sperime
Il vino nel legno. Progetto ToSca: carati toscani in legno di castagno locale
Kick-off meeting per il progetto ToSca sul tema del rapporto tra il vino e il legno con particolare riferimento alla tradizione toscana di uso dei contenitori in legno di castagno.
La professione forestale nell’era della closer to nature selvicolture, un seminario ad UNIFI
Quali sono i possibili sbocchi professionali della laurea in Scienze Forestali? Come sta cambiando il settore alla luce dei recenti sviluppi in direzione di una selvicoltura più vicina alla natura
È davvero necessario e utile "umanizzare" alberi e natura?
L'umanizzazione edulcorante della natura fa davvero bene al rapporto tra esseri umani ed ecosistemi? Una riflessione a partire da un articolo del Guardian.
Crisi climatica e alberi: meglio fare arboricoltura da legno che "boschetti”!
Per prolungare la fissazione di CO2 oltre la vita delle piante queste devono avere un fusto idoneo ad essere trasformato in manufatti di lunga durata.
Tra ciliegi e social network
Nell'editoriale del numero 253 di Sherwood (2021) Luigi Torreggiani si interroga sul fatto che nell'acceso dibattito tra conservazione e utilizzazione c'è sempre un grande assente: la selvicoltura
Crisi climatica: perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo
Perché NON pianteremo 100 miliardi di alberi in breve tempo valuta criticamente la possibilità di mitigare la crisi climatica con la piantagione di alberi nelle aree periurbane di tutto il Pianet
Verso un Manifesto condiviso per una Selvicoltura più vicina alla Natura
Raccolta commenti e sottoscrizioni al "Manifesto per una Selvicoltura più vicina alla Natura"
Perché la goccia ha infine scavato la roccia? Nuove riflessioni a seguito del dibattito sul “doppio vincolo” paesaggistico
Alcune considerazioni a seguito di un interessante commento apparso su Georgofili.info, a cura della Professoressa Nicoletta Ferrucci
Un “viaggio sentimentale” nei boschi italiani
Dicono che troverete più nei boschi che nei libri. E che gli alberi vi insegneranno cose che nessun maestro vi dirà. È vero! Ed è proprio questa la meraviglia del bosco.
La foglia di fico | Storie di alberi, donne e uomini
Pascale ci consegna un diario, un itinerario all’interno del suo “giardino botanico”, dove vengono raccontati i traguardi, ma anche i fallimenti e le debolezze di una vita intrecciata alle pi
Antennae - Se gli alberi potessero registrarci
Un podcast di RAI Play Sound che, in cinque puntate, prova a raccontare altrettante storie scritte a partire dall’immaginario Archivio Dendrosonico: per parlare del presente e del passato.
Dalla “questione forestale” alla legge Serpieri
Recensione del libro "Alle origini del diritto forestale italiano - Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923" di Federico Roggero.
La sostenibile leggerezza del legno
“La sostenibile leggerezza del legno”, una serie podcast promossa da Assolegno di FederlegnoArredo insieme a quattro aziende leader del settore: Friulsider, Marlegno, Rothoblaas e Xlam Dolomiti
Il suono del legno
Un video che ripercorre a ritroso il viaggio che ha per protagonista il legno di risonanza di un abete rosso trasformato in un clavicembalo artigianale di elevatissima qualità acustica.
Altre news
Testo testo con tooltip altro testo dopo tooltip













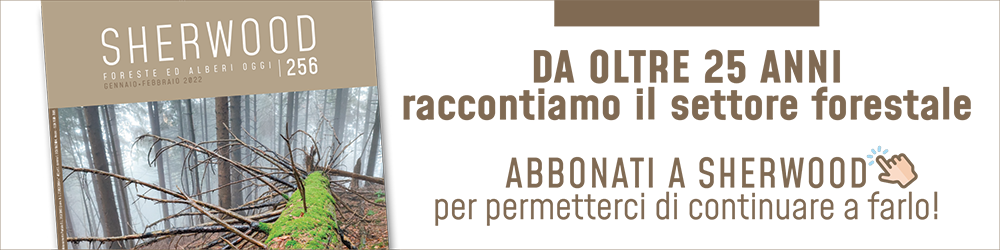
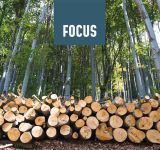
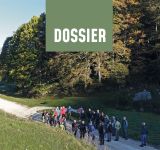















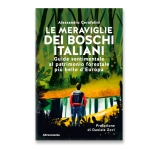
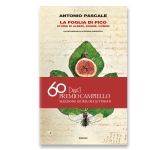
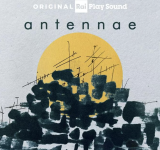
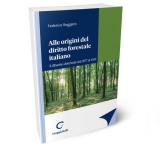














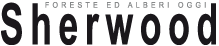


 E poi Aggiungi alla schermata principale.
E poi Aggiungi alla schermata principale.